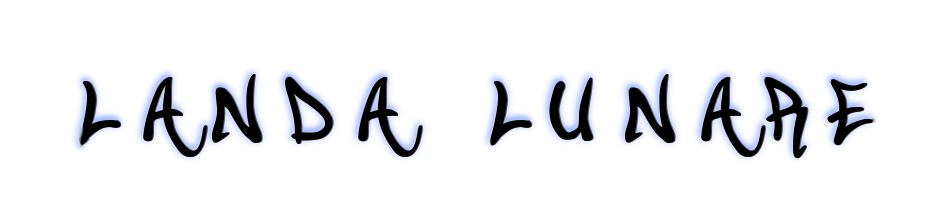Capitolo 5 – Vernice plus
Jacopo si trova ancora una volta al buio. Il respiro affannoso rende lo spazio claustrofobico mentre piano cerca tra le coperte l’oggetto dei suoi pensieri. Nella sua testa le parole nere si accavallano e cerca un appiglio, far combaciare le sue costruzioni mentali con quelle frasi.
Sprofondate nel suo cuore preoccupazioni! State arrugginendo un cuore d’acciaio.
Se può il vento che tanto s’impegna a far sbattere gli scuri porterà queste parole al destinatario nel tempo in cui le ali di rondine portano la primavera. L’inverno del suo cuore sarebbe così portato al disgelo, svegliato dal suo letargo ritroverebbe la voglia dei germogli di scrollarsi di dosso il terriccio e arrivare a nuova vita.
Jacopo si gira e si rigira, la gamba si culla da sé e le estremità delle sue dita si ghiacciano. Il sangue è tutto nel suo petto, nel suo collo, aiuta i polmoni. Gonfi. Sgonfi. Gonfi. Sgonfi.
Come non pensare? Via, maledetti corvi, nuvole nere sulla sua fronte! Allora è vero che ogni brutto pensiero ha le sopracciglia contratte!
Jacopo s’abbraccia, come non s’abbraccia neanche un figlio, nel nero delle lettere di cui non trova un incastro. C’è un gran fracasso tra le sue costole, un suono antico quanto il primo uomo che trattenne il respiro, nel freddo di una caverna.
Si contrae l’addome come se con gli occhi della pancia, che sono i più profondi e solleciti dei tanti disponibili all’uomo, vedesse arrivare il colpo. Tenere duro, deriverà da lì, il detto? Da quella contrazione?
Le dita non possono ringraziare, o complimentarsi, o dire quanto tutto questo sia insopportabile.
State molto attenti ora, perché Jacopo ha fatto una cosa. Jacopo si è sporcato nel profondo con dei colori che non gli appartenevano. Sì, dovete proprio saperlo, ha tinteggiato buona parte della camera che tiene lì nascosta, quel luogo sconosciuto a tutti se non agli occhi dello stomaco, che certo sono reattivi e onniscenti a sufficienza. Così quando la vernice si è messa le gambe in spalla… con la volontà di chi sarebbe rimasto per sempre sia chiaro, non è mica fuggita a cuor leggero, solo che gli eventi… Dicevo, quando la vernice ha tagliato i rapporti col pennello, la stanza è rimasta metà colorata, e metà bianca.
Quindi adesso Jacopo è davanti a una scelta.
Primo: può tinteggiare tutto di bianco, e chi s’è visto, s’è visto. Ha così tante parole che potrebbe riempire superficie e volume tante volte da superare le passate consigliate per la buona tenuta del colore. Sì però… poi si vede dove c’era il colore prima perché il punto diventa più spesso, e prima o poi l’intonaco cade e si vede… Non si può fare. E poi se aveva deciso di tinteggiarlo quel bianco, ora non si torna indietro, non sarebbe… autentico!
Secondo: può cercarsi un’altra vernice e finire la stanza con quella, ce ne saranno sugli scaffali! Sì, senz’altro. Sì, però… Questa non tiene. Questa non brilla. Questa è buia. Questa è stupida. Stupida vernice!
Terzo: Ritrovare quella medesima vernice! Ok, questo è folle! Jacopo, la vernice è andata via! E non puoi dirle che è stata una gran vernice, che quando vorrà pitturare qualcosa tu ci sarai sempre, che è bravissima ad assolvere i suoi compiti di tinteggiatura per diventare una vernice plus! Eh non puoi, perché daresti fastidio a quella vernice! Meno ti vede meglio sta.
Jacopo capisci che meno ti vede meglio sta, la vernice?
Capisci che meno la cerchi e più lei riuscirà ad essere la vernice che vuole ed è destinata ad essere?
Jacopo, come vedi delle tre opzioni non hai scelta! Cioè davvero, non hai scelta, nessuna, nessuna delle tre è una strada percorribile!
Chiudiamo la stanza?
La spalanchiamo, per chiunque?
Jacopo soffiando dalle narici un taurino e rovente “NO” è in questo istante monolitico e fortissimo, alto svariate leghe sul tetto del mondo, reggendo dolcemente la volta celeste col suo indice sinistro. Sceglie d’essere il più forte possibile, per quella Vernice.
Io so solo che Jacopo è nel buio delle sue lettere. Respira a fondo. Scoprendo le difficoltà di fare parallelismi con colori in barattoli.
Capitolo 5 – Cortomaltese
Jacopo vede che te ne vai sbattendo la portiera. Uno schiaffo di spostamento d’aria.
Jacopo è sempre al palo, sempre fermo, accarezza il suo gatto, guarda oltre le finestre, quelle del suo monitor, e conta.
Jacopo si prende un altro no, se lo mette in borsa, e cammina con i sassi nelle scarpe che vorrebbe tirare, tirarseli addosso, rimanerci sotto la valanga dei suoi sassi nelle scarpe.
Jacopo fuma, si stappa una bottiglia, usa la pornografia e i videogame, si spegne.
Jacopo ti guarda ancora negli occhi, non lo fa con nessuno ma con te sì, dannazione, ti guarda come se dovesse capire misurando il tempo che ci mette il suo sguardo ad arrivare al cuore quanto profonda sei. Ti fa luce dentro, si porta in te, ti fa ancora l’Amore come una volta, quando dall’altra parte del tavolo giocava a prendere tutte le tue occhiate e a farsi correre i brividi sulla schiena coi tuoi sorrisi. Spudoratamente in mezzo alla gente. A mezz’aria. Ma tu non ti ricordi queste parole.
Jacopo brucia di banalità ogni giorno, di routine ogni secondo. Tossisce come tutti. Ha la voce roca, si starnutisce addosso. Spacca il volante a pugni. Come tutti.
Jacopo è sé stesso, lo è sempre, a costi di farti male e di ucciderti. Ce lo deve. E tu?
Jacopo vede le tue bugie e vede oltre, e vede. Vede. Vede. Vede. Vede. Fissa il vuoto e vede tutto. Vede la stanza, le pareti rosse, un letto, un hotel, e gli manca la forza di descriversi il resto anche se l’ha già fatto tante volte.
Jacopo ogni giorno discrimina la sua diversità. Quella di ieri.
Jacopo perde sangue dal naso e dagli occhi, e a volte anche quando viene. No, non succede e non vorrebbe succedesse, ma a volte pensa proprio che quello che gli monta dentro deve essere sangue. Infondo è lì che incanala le sue paure, ansie e frustrazioni.
Jacopo fa un altro passo. Ogni numero è un passo lo capisci?
Ci metti una parola davanti a un numero, sempre la stessa… e tutti si aspettano di andare avanti. Ma stiamo andando indietro, sempre di più, ogni parola ci guida alle origini. E srotolato fino al bandolo, la matassa seguirà la sua fine naturale.
Jacopo è quasi arrivato. Si ferma per un po’. Respira aria buona dal filtrino.
L’ultima tappa…. l’ultima Thule…. L’Arcadia… La meta. La metà.
Guardo l’Oceano erculeo. L’ennesima fatica. L’ultima.
Pronta per il Mare aperto Sorella? Pronta per l’America, su una rotta diversa dalla mia? Che le mie tempeste non vedano le tue.
E le tue non vedano le mie.
E io non affondi prima di te e tu prima di me.
Che si possa scoprire da soli insieme.
Jacopo. Cortomaltese.
Capitolo 4 – Quel momento lì
Jacopo si trovò consapevole dell’estrema forza di volontà aggiuntiva che d’un tratto gli veniva chiesta. Si sentì meno vuoto.
Sentiva quel momento in cui gli impegni gli franavano addosso come un autentico momento di vita in cui riusciva a capire la sua carenza: il Motivo Per. In tutte le altre fasi della giornata passava solo da una scrivania ad un’altra, e il suo tempo libero lo dedicava a svuotarsi. Il suo rituale collaudato, la sua autoimposizione, il demone lo portava costantemente in un vuoto astrale, privo d’aria, in cui soffocando doveva disperatamente trovare l’uscita nel suo baratro personale. Passare da un vuoto ad un’altro.
Era una passeggiata quotidiana, verso un burrone inevitabile in cui non era più una scelta buttarsi. Ci cascava ogni volta, inciampava e nella sua Disperazione dei Tre Minuti disintegrava tutto ciò in cui credeva. Duale nel suo corpo e nella sua mente. Cavaliere integro, e lurido Furfante. Nessuno prevaleva, ma a lui sembrava che le macchie avessero sempre la meglio sul bianco. Poteva avere abiti candidi lunghi venti metri, e trovando comunque una macchia piccolissima non riusciva a non sentirsi sporco. Si lavava in continuazione anche tre o quattro volte al giorno. Doccia su doccia a ogni Disperazione dei Tre Minuti. Voleva strapparsi la pelle con l’acqua bollente, raschiarsi via e strappare il vestito in brandelli così minuscoli che quella maledetta macchia sarebbe stata solo un puntino insignificante e irricostruibile, indecifrabile anche alla sua memoria.
Ma quando Jacopo si sentiva oberato e incapace, allora tirava fuori il suo meglio. Non aveva i Tre Minuti, non poteva.
Jacopo riuscì ad avere un po’ di pazienza e calmò la sua urgenza di correre freneticamente per battere sé stesso, si perdonò.
Non sarebbe durato. Jacopo sarebbe caduto ancora in quel pozzo senza fondo così stretto che lo faceva scendere ora dopo ora con una lentezza desolante, un’angosciosa e opprimente discesa passata a scalciare fino ai Tre Minuti in cui sembrava allargare di forza le pareti precipitando indefinitivamente, a una velocità elettrica per Tre lunghissimi minuti per cascare perfetto su una sedia in una stanza poco luminosa col suo monitor, e di nuovo irrimediabilmente sporco. Solo, e quindi unico colpevole. Doveva lavarsi e grattasi, asciugarsi e dimenticare ficcandosi dentro qualcosa a costi di mangiare tutto il cibo in casa.
A volte però i Tre Minuti di Disperazione arrivavano quando era fuori, magari al lavoro o per strada, e percepiva gli occhi di tutti addosso col peso di un cappotto in Estate. Tutti sapevano di lui anche se non lo guardavano e non c’erano al suo Rituale, e poi lo compiva.
.
.
Compiuto.
.
ed era sicuro di avere un marchio addosso, Quella macchia che tutti potevano vedere e bisognava camminare veloci, più veloci, guardarsi, schivare le occhiate non fatte, le frasi non dette, non ascoltare cioè, camminare, veloce, rifugiarsi a un tavolo, ordinare un caffè, per vincere l’imbarazzo di stare solo al tavolo, e fumarsi una sigaretta perché tutti lo avrebbero notato se stava a far niente davanti a un bar, e così tutti avrebbero pensato che aspettasse qualcuno, e poi quando finiva farsene un’altra, nel panico di non sapere che cazzo fare, e non ricordarsi perché fosse lì, e camminare ancora, e sentirsi sporco, proprio lì, e volersi scorticare e non potere perché in pubblico non è carino levarsi la pelle, e non potersi lavare come vorrebbe, e volersi tuffare nel fiume, e scuotere la testa, pensando a cos’era, e aver solo voglia di tornare indietro, non comporre quel numero, e prendere quel numero e cancellarlo, e bloccarlo, per cercarne un’altro la prossima volta e ricominciare, o ricordarsi lo stesso e riprovare, e sporcarsi ancora, e ancora, e Ancora, e ANcora, E ANCOra E ANCORA E ANCORA E ANCORA E ANCORA E ANCORA E ANCORA…
Ansimare.
Ecco, in quel momento lì, tuto questo non c’era. E anche se ansimava si sentiva bene, perché era un ansimare pulito. Puro. Sano. Vitale.
“Per oggi basta così”.
Innamor-andato
Ho capito a vent’anni che non si può chiedere aiuto restando in silenzio.
Ho perso il treno, anche se mi si era fermato davanti, e a porte spalancate il controllore urlava di salire. Pensavo di aver viaggiato abbastanza, di aver dato a quella ferrovia abbastanza chilometri del mio viaggio. Ma ora alla stazione, mi rendo conto della morte del restare ad aspettare, e la mia mente è troppo appannata per comandare alle mie gambe di camminare. Sono stanco, e non vorrei. Non ho ancora l’età per riposarmi, eppure… Dove sarà ora quel treno? Avrà sconfitto l’orizzonte? Dimmi, dove si incontrano il cielo e la terra? Che c’è dopo? Tu lo sai. Me lo racconterai?
Sai.
Ragazza che non ho.
Proprio adesso che sei così lontana da me come non mai, proprio in questo momento sento il bisogno di parlarti.
Sei una porta con doppia mandata, e anche la finestra dal balcone da cui di solito scavalcavo quando non avevo le chiavi, non mi sarà d’aiuto. Ho costruito una fortezza tutta intorno a te, e poi ti ho chiesto di alzare il ponte levatoio per chiudermi fuori.
Adesso che ho completato la mia opera di esclusione, guardo al risultato.
Ho sbagliato tutto.
Ragazza che non ho, ti ho sempre parlato troppo poco rispetto a quanto meritavi, e a quello che avrei voluto. Sono fatto così, sono bravo a costruire fortificazioni perché il primo a circondarsi di mattoni sono io.
Ragazza che non ho, posso solo chiederti scusa in un posto in cui so che non mi leggerei. Perché il mio Amore possa esistere senza gravarti. Tutto il male, l’ho creato io. Perdonami e se mi incontrerai di nuovo leggi i miei occhi, e senza pensieri capirai che saranno lì solo per specchiarti. Tu e solo tu li conosci, e loro solo te conoscono. Su cos’altro dovrebbero posarsi? Si perderebbero nel vuoto, e cercando di capire dove questo finisce, cadrei in avanti.
Io dovevo scriverti un’altra volta, perché si possa urlare che a questo Mondo qualcuno ama ancora, e c’è speranza.
Ho rovistato nei miei pensieri, li ho ispezionati, ho elaborato e metabolizzato tutta la bile, avevo deciso di parlarti ma ho aspettato. Ed era già troppo tardi. Troppo. Per entrambi. Quella sera non ci saresti stata, e avrei visto la candela sul tavolo spegnersi per conto suo.
Perdona questa testa che pensa troppo, e prima ancora dovrò farlo io.
E’ sempre un brutto periodo l’inverno, con l’ombra della solitudine che riempie le stanze della mia mente, come un gas che esploderà dirompendo in una vampata di luce. Un ultimo lampo, come a sbeffeggiare i miei tentativi di scacciare la tenebra.
Sembra tutto uno scherzo. La vita è cabaret allo stato puro.
Non riderò. Non riesco più a trovare divertente il black humor.
Capitolo 3 – Genesi
Il ragazzo ha dodici anni.
Passa molte ore per conto suo, ma non si sente solo.
Il ragazzo ha uno schermo, una tastiera e una connessione. Curiosità.
Naviga in un mondo che non è di nessuno, non ancora. Non ci sono frequentatori occasionali, saltuari visitatori che consumano e se ne vanno. E’ un universo consistente, di persone permanenti. Di nomi inventati e di personalità, che come lui sono quasi sempre attive, dalle dodici alle sedici ore al giorno.
Per il ragazzo è un gioco, ma autentico.
Non crede sia diverso dalla vita reale, non finge di essere ciò che non è. Si comporta esattamente come nel Vecchio Mondo, ma con qualche paura in meno. Non teme di essere preso in giro, o picchiato. Se succedesse, con un pulsante spegnerebbe tutto. Sente di poter controllare, di poter tenere quello che gli piace e scartare quello che lo infastidisce. Ferisce.
Il ragazzo è sé stesso. Solo con gente più grande. D’estate, i suoi coetanei sono fuori, a correre dietro a un pallone. Neanche sanno cosa vuol dire, chattare.
I più grandi lo capiscono. Lo trovano più maturo, più sveglio della sua età. Si è sempre trovato meglio con la gente adulta.
Ha messo le mani in un mondo di persone cresciute e distanti centinaia di chilometri da lui. Fruga, scava, trova. Indaga.
E’ cresciuto con questo mezzo ed è convinto di conoscerne le potenzialità e i limiti.
Non sempre capisce tutti i discorsi, e allora domanda.
Non sempre sa cosa cercare, e allora si lascia trasportare.
Non sempre sa cosa lo aspetta, e allora si fa sorprendere. E gli piace.
Capita che senta parlare di argomenti fino ad allora proibiti, e scopre che sono profondi e inesplorati. Vuole andare a fondo, a loro e a sé stesso, capirsi prima degli altri. Bruciare le tappe.
Domanda ai ragazzi più grandi com’è fare sesso, se è diverso dal masturbarsi. Per lui è un gesto vuoto, compulsivo, si provoca piacere ma non sa bene come funzioni e perché. Sa che gli piace, e gli basta.
Il ragazzo si spinge oltre. Trova nelle chat anche uomini adulti. Li cerca. E loro cercano lui.
Lui è ciò ce loro vogliono, e lui vuole capire cosa. Per lui il sesso è un argomento vuoto, come tanti. Ne parla liberamente. Spiega cos’è per lui, e si fa spiegare cos’è per loro. Scopre cos’è l’omosessualità, e che è più diffusa di quanto pensava. Il Vecchio Mondo forse non è ancora pronto, e per questo quella è una buona patria per loro, e una buona scuola per lui.
Gli fanno domande strane.
“Sì, ho già assaggiato il mio sperma ma non ha un gusto particolare”
“No, non mi sono mai masturbato con i miei amici”
“Mah non lo so come sarebbe provare…”
Neanche lui capisce bene cosa significhi provare. O parlare di queste cose con adulti. Non capisce che stanno usando le stesse parole ma lingue diverse.
Ne conosce tanti, ma dopo due giorni spesso si stufano della sua curiosità superficiale e diffidente; ha già sentito parlare di qualcuno che c’è cascato, e lui non sarà il prossimo. Si dice.
Uno, in particolare, lo colpisce.
Un maestro di sci.
E’ gentile con lui. Non si stufa subito. Lo ascolta, e gli risponde. Si sentono spesso.
Si sentono su C6.
Si sentono sul cellulare.
Il ragazzo è colpito. E si spinge un po’ oltre, ma comincia a sentire la paura di sbagliare.
L’insistenza aumenta.
“Se sei curioso di provare io ci sono. Dove abiti di preciso?”
“Sai, io insegno anche ai ragazzini, in piscina… So dargli il loro tempo, non li butto in acqua, sono lì, li sostengo, e quando sono pronti, nuotano. Con te sarebbe lo stesso.”
“Sei esattamente quello che cercavo…”
“Allora? Ci vediamo o no?”
Il ragazzo è confuso. Per lui il sesso non è importante, infondo. Ma ha un blocco, imposto in principio, come un istinto passato dai suoi maestri. Non sa superarlo. Eppure non sarebbe niente di grave, si dice, anzi anche interessante. Chiarirebbe molto anche a lui.
L’estate sta finendo, e con la scuola non avrà più occasione di sentirlo.
Il maestro di sci gli da l’ultimatum.
E lui.
Accetta.
Nei primi giorni di settembre.
In una macchina.
Una strada sterrata.
Su dei sedili posteriori pieni di buchi di sigarette.
Il bacio. Battito cardiaco. Un odore fortissimo.
Portiere bloccate e un disagio improvviso.
Il cielo appannato.
Due mani robuste e una barba ispida.
Sapore aspro.
Aria condizionata, sole pomeridiano che, si nasconde in una nuvola.
Il motore acceso.
La solita via.
La solita porta.
Il solito letto.
Il solito cambiamento.
Lo schermo spento.
Capitolo 2 – Chapeau
“Porta pazienza, ci sentiamo per domani”
Finiva più o meno così la telefonata della mia vita. Accovacciato per terra.
Piacere, Jacopo. E qui finiscono i convenevoli.
Fumavo tre sigarette di fila, dopo che lo schermo del cellulare si era spento. Non avrei mai detto che fosse il fumo a tenermi in vita.
Cartine finite, e nessuna voglia di studiare fuori dalla biblioteca illuminata. Andai a prendermi un pacchetto.
Ero come voi, circa un anno fa. Forse peggio. Del tipo: le donne essenzialmente, sono troie. Trovatene una che scopa bene, o quanto meno ogni volta che tu ne abbia voglia. Possibilmente che faccia pompini. Non servono a molto altro. Se la trovi tientela stretta, ti sei sistemato a vita.
A volte capita di cambiare idea, per lo più grazie a qualcuno. Succede di essere una persona migliore di ciò che si è. O di volerlo essere al punto di diventarlo.
Quella sera mentre camminavo, il Mondo mi chiedeva perdono. Lo sentito quasi ansimare e piangere attorno a me, e abbracciarmi coi lampioni. Io rispondevo “Sta sera no, grazie, ripassa domani”. Il giorno dopo passa ogni cosa. L’incazzatura che ho da una decina d’anni no, ma quella è più con me stesso, e non ho grandi speranze passi mai.
In Italia se ti metti il cappuccio in testa, specialmente di notte, sei uno spacciatore o un violentatore. In Inghilterra invece è piuttosto normale, col freddo che fa.
Una sera capisci Bukowski tutto d’un colpo. Ha sofferto più lui d’Amore di un Dante qualsiasi, perso a sbavare dietro un angioletto privo di impulso sessuale.
Poi passi sotto la luce del tabaccaio, e si spegne. E il distributore non ti accetta i 5€, e quando lo fa non ti da il resto. Marlboro rosse. Aspiro ma non sento niente. Loro dovrebbero uccidermi, dicono.
Non fa poi freddo, se cammini veloce.
Capita che per andare avanti qualcosa devi lasciartelo indietro. Che se il tuo cesto tiene ottanta mele e tu ne hai cento, passi una vita a raccogliere quelle che cascano, e intanto marciscono tutte. Se sei quello che le raccoglie, affari tuoi, stai scegliendo il tuo modo di lasciare questo Mondo un po’ come tutti. A me è capitato di essere una mela, e di salire e cascare non ne avevo più voglia, per cui sono rotolato via.
E peggio guidare quando non riesci a stare sulle gambe, piuttosto che quando sei ubriaco. Quella sera dormii in macchina. Chiamatelo vittimismo, io non ne avevo voglia di tornarmene a casa, e tanto basta per decidere di non farlo.
Non ricordo cosa successe tra il mio risveglio nel parcheggio alle 7.30 della mattina, e la mail che mi comunicava con un burocratese formale e rispettoso, di essere stato ufficialmente preso a calci in culo dalla mia Università, per una faccenda di “appropriazione indebita di bene pubblico”, ma suppongo sia trascurabile.
Cara vita: Chapeau.
Capitolo 1 – L’uomo
Ho ripreso in modo compulsivo. E’ una cosa che mi disturba, fa parte del mio ciclo di distruzioni, annientamento personale low-cost con un pizzico di piacere. Gratificazione monocromo. L’altalena emotiva che mi fa sentire bene, esplodere e poi, solo tanta voglia di buttarmi dentro me stesso, che è il posto peggiore che conosco. Ci sarà un giorno in cui finirà la spinta, e non mi aspetto che l’altalena si fermi nel punto più alto. Se dovessi usare la stessa metafora per descrivere la mia settimana, il weekend sarebbe il punto di minimo dell’oscillazione. Il vuoto totale, riempito solo da un misero massacro contro me stesso, una partita già vinta.
L’apice è il sabato sera, un concentrato libidinoso di tutti i vizi peggiori, da rubare i biscotti sulla credenza a provare a mescolare noce moscata e ammoniaca in un pentolino per estrarci allucinogeni sani quanto i migliori solventi nelle baraccopoli brasiliane. Segue una lenta ripresa, passando le successive ventiquattro ore a espellere un po’ di tossine dall’esofago e restando rannicchiato su delle coperte di lana vecchie almeno quanto me, tra delirium tremens e mal di testa da patibolato.
Se mi dai del vittimista ormai non m’incazzo neanche più, mi giro dall’altra parte e tanti saluti.
Questa ossessione è un raptus violento, mi svuota l’anima e mi seda. Un po’ come espellere la mia passione distruttiva, in squallitudine. Prolungata fin dopo l’atto dalla vergogna. L’unica è non pensarci.
Fare, venire, pulire senza guardare,
raccogliere in un fazzoletto,
non incrociare lo sguardo con lo specchio,
buttare tutto nell’indifferenziata.
Riprendere a vivere fingendo
di non essersi uccisi
neanche un po’,
aprirsi una birra,
fumarsi una cicca,
cambiarsi le mutande tre volte al giorno.
Gettarsi nel Tempo e buttarsi via. Sottile metafora di vita pratica.
Se a trentanni non ti riduci così, bravo. O non ti sei messo in gioco, o hai due palle come la Thatcher. Dove voglio andare a parare?
Che tu la notte riesci a dormire serenamente, mentre io devo sentirmi in colpa ad odiare ciò che Amo.
E ora fai trentuno: le ho legate tutte assieme le tue belle frasi e definizioni da Zingarelli piene di umanità come un pistone, e mi ci sono impiccato.
Le cose migliori che ho provato erano così sporche che a guardarle ci si imbrattava di piacere, e a provarle si diventava fango. Perché, tu come ci diventi argilla?
Fidatevi. Fottetevi.
Prologo – Inizio.
“Non riesco. Sono stanco.”
Sono le frasi che mi frullano nella testa, da settimane, da mesi.
E proprio adesso che il mio orologio batte gli ultimi rintocchi, trovo la forza di urlarti con tutto il mio fiato.
La mia essenza fluttua ma il mio corpo ancora resiste al giacere, restando a carponi.
Adesso che la mia ora scade trovo quel colpo di tosse che col sangue imbratta il pavimento – quel liberatorio sussulto che dallo stomaco mi lascia riversare un grumo di cancrenoso sangue davanti ai miei occhi. Tutto il mio dolore, in un unico bolo vermiglio di vomito che puzza di Anima.
In questo modo brusco stacco la spina da questo mondo, tenendomi la pancia preso dai peggiori dolori al mio stomaco e sbavando come un cane. Non ho mai voluto guardarmi dentro e, ironia della sorte, ora mi ritrovo su questo pavimento. E come sospettavo, non mi piaccio.
Mi trascino rantolando sui vetri rotti, appoggiato al bordo della vasca. L’ennesimo conato mi fa rigirare gli occhi e martella la mia testa con “Basta basta basta basta basta basta …”. Le mie mani tese sporche di sangue, gin e bile lasciano graffi rossi liquamosi sulle piastrelle alle pareti, colando in piccole pozze alla base del muro; oasi malvagie da cui si abbevererà l’animo curioso dei miei becchini.
Eppure con quest’ultimo fiato, io ti grido al cielo per l’ultima volta. Fa che sia l’ultima volta Dio in cui non credo, se esisti lascia al tuo peggior nemico di togliersi da questa Terra senz’altro dolore, e se come penso tu non esisti, allora sono felice di portarti sulla mia bocca ora, che è unta dei peggiori demoni partoriti da mente insana. In entrambi i casi non hai mai lenito il mio dolore – il dolore per lei e lei, adesso, urlo.
“Dulcinea!”
Già mi pento di averla pronunciata in un momento così ingrato, come se l’avessi sporcata. Ma andandomene voglio portati con me, almeno un frammento di te, deve morire con me.
Nella mia testa compaiono lampi, ricordi.
Tra questi una sfera opaca e incandescente. Ricordo le sue parole, le sue frasi, tutti gli echi nella mia testa.
Fa che sia l’ultimo ricordo, Dio presunto! L’ultima immagine per un Don Chisciotte che non può scegliere di essere diversamente, mentre Dulcinea un giorno si è chiamata Giulietta e ora cerca un Romeo.
L’Amore; che fregatura.